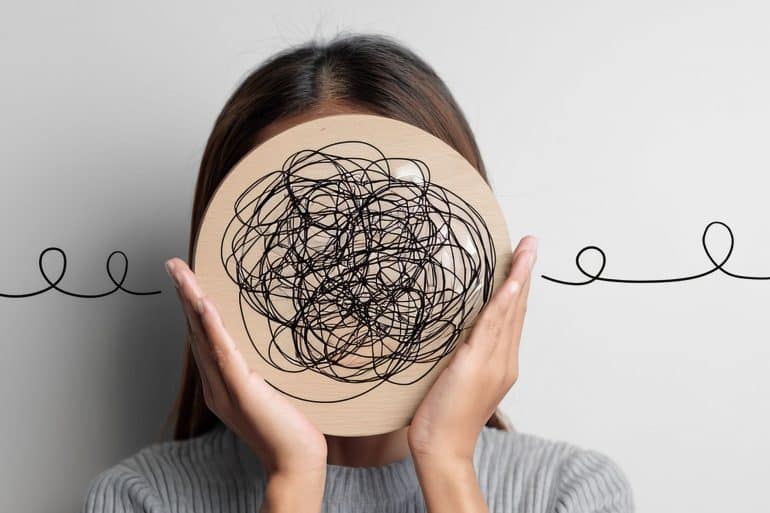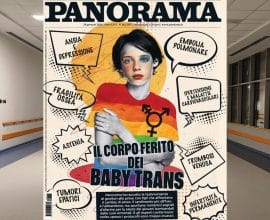Confondere l’identità transgender auto-riferita con la disforia di genere clinica
Introduzione
Negli ultimi anni, la ricerca in medicina di genere ha visto emergere una questione metodologica cruciale: la crescente confusione tra l’autoidentificazione transgender nella popolazione generale e la prevalenza clinica della disforia di genere.
Come analizzato da Schwartz e Lal nello studio denominato “Order of Magnitude: On the Critical Distinction Between Self-Reported Identity and Clinical Prevalence in Adolescent Gender Dysphoria: A Methodological Commentary”, pubblicato nel mese di ottobre 2025 nella rivista “Journal of Sex & Marital therapy”, questa confusione non è solo teorica, ma produce effetti concreti nella pratica clinica e nelle politiche sanitarie, rischiando di espandere l’ambito di applicazione dei trattamenti medici a popolazioni che non soddisfano criteri diagnostici clinici.
Il tema è emerso con forza in risposta alla Evidence-Based Critique of the Cass Review, pubblicata dal Yale Law School Integrity Project (McNamara et al., 2024). Tale documento contesta le conclusioni della Cass Review (Cass, 2024) sostenendo che il sistema britannico non abbia offerto un accesso sufficiente alle cure ai giovani transgender. Gli autori affermano che “meno del 10% dei giovani che potrebbero beneficiare dell’assistenza l’ha effettivamente ricevuta” (McNamara et al., 2024, p. 18). Tuttavia, come osserva Schwartz, questa stima dello 0,6% deriva direttamente dal censimento britannico 2021, dove lo 0,54% degli intervistati si era autoidentificato come transgender (Office for National Statistics, 2021), senza alcuna verifica clinica.
Schwartz (2025) sottolinea che tale operazione rappresenta una sostituzione metodologica grave: un indicatore sociologico di identità viene impropriamente utilizzato come misura clinica di prevalenza. Questo errore, apparentemente tecnico, ha implicazioni cliniche ed etiche profonde, poiché rischia di legittimare l’estensione di trattamenti medici irreversibili a popolazioni non diagnosticate con disforia di genere.
La distinzione clinica: identità vs diagnosi
La distinzione tra autoidentificazione transgender e disforia di genere clinica è chiaramente definita nei manuali diagnostici e nelle linee guida internazionali.
Il DSM-5-TR (American Psychiatric Association, 2022) definisce la disforia di genere come una marcata incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato, associata a disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale e relazionale.
Come evidenziato da Drescher (2025), non ogni persona che si identifica come transgender soddisfa questi criteri, né manifesta necessariamente un disagio clinico che giustifichi un intervento medico.
Analogamente, una revisione sistematica del WPATH (Baker et al., 2021) distingue tra studi basati su cartelle cliniche e indagini su popolazioni auto-selezionate, avvertendo che i risultati possono variare di ordini di grandezza. Collin et al. (2016) e Goodman et al. (2019) confermano questa discrepanza: la prevalenza clinica storica della disforia di genere si colloca stabilmente tra lo 0,0046% e lo 0,0075% della popolazione, ovvero da 4,6 a 7,5 individui ogni 100.000.
Questi dati contrastano nettamente con le recenti stime di autoidentificazione, spesso superiori di due ordini di grandezza.
La Cass Review (2024) ha espresso preoccupazione per tale scarto, segnalando che l’aumento delle diagnosi “è molto più rapido di quanto ci si aspetterebbe per una normale evoluzione dell’accettazione di un gruppo minoritario” (p. 26).
Quantificare la discrepanza
Confrontando la prevalenza clinica storica (0,0046–0,0075%) con la stima dello 0,6% utilizzata da McNamara et al. (2024), emerge una discrepanza di 80–130 volte.
Secondo Schwartz (2025), tale differenza non è un mero artefatto statistico, ma il sintomo di una “deriva epistemologica” nella medicina di genere: un passaggio da criteri diagnostici rigorosi a indicatori auto-riferiti di identità.
Uno studio su JAMA Pediatrics (Hughes et al., 2025) ha rilevato che circa lo 0,1% degli adolescenti statunitensi aveva ricevuto ormoni di affermazione di genere entro i 17 anni — un tasso definito “raro”, ma comunque 15 volte superiore alle prevalenze cliniche storiche.
Se si accetta il dato di riferimento di Arcelus et al. (2015), oltre il 90% dei giovani oggi medicalizzati non rientrerebbe nella popolazione clinica per la quale tali trattamenti erano stati concepiti.
Discussione: offuscamento diagnostico e implicazioni etiche
La questione metodologica sollevata da Schwartz non riguarda l’autenticità delle identità di genere, ma la necessità di garantire che i percorsi medici siano fondati su diagnosi cliniche solide.
Il fenomeno dell’“offuscamento diagnostico” descritto nella Cass Review (2024) — ossia la tendenza ad attribuire esclusivamente al genere problematiche psichiche complesse — rischia di portare a medicalizzazioni inappropriate.
Spencer e D’Angelo (2025) avvertono che un approccio centrato unicamente sul genere può “affrontare la presentazione sintomatica superficiale del paziente, trascurando le cause sottostanti”.
In termini etici, questo solleva questioni di non maleficenza e giustizia: trattamenti irreversibili somministrati a pazienti non clinici possono violare il principio di non nuocere e distorcere la destinazione delle risorse sanitarie (Bayraktar, 2025; Drobnič Radobuljac et al., 2024).
In questa prospettiva, la “fusione metodologica” tra identità auto-riferita e diagnosi clinica non è solo un errore di categorizzazione, ma un problema di responsabilità epistemica nella pratica medica.
Conclusione
La crisi metodologica descritta da Lauren Schwartz (2025) mette in luce una tensione crescente nella medicina di genere contemporanea: l’espansione dei criteri di inclusione ai trattamenti a scapito della definizione diagnostica.
Per ristabilire la chiarezza necessaria, Schwartz propone un ritorno a criteri clinici verificabili, valutazioni multidisciplinari e l’uso di strumenti psicometrici per distinguere tra disforia persistente e incongruenza transitoria.
La medicina di genere, per restare eticamente fondata e scientificamente solida, deve riconciliare la compassione con il rigore, proteggendo la dignità del paziente attraverso la precisione diagnostica.
Solo così sarà possibile garantire un’assistenza realmente basata sull’evidenza e rispettosa dei principi fondamentali della bioetica.