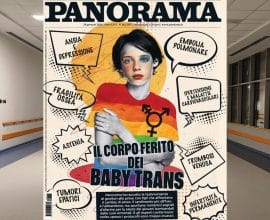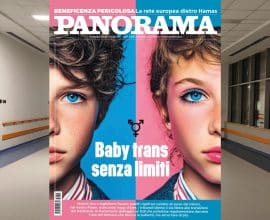Nuovo studio conferma la necessità della psicoterapia esplorativa per la disforia di genere
Un recente studio francese di Cognet-Kayem et al., pubblicato sull’importante rivista scientifica Archives of Sexual Behavior il 12 agosto 2025, dal titolo “Transidentification in Adolescents and Young Adults: Understanding Parental Concerns to Improve Psychological Support for Families”, ha analizzato le esperienze genitoriali di fronte alla rivelazione di una identità transgender da parte dei loro figli adolescenti e giovani adulti.
I risultati, in linea con precedenti ricerche come quelle di Littman (2021) sulla rapid-onset gender dysphoria, evidenziano come la percezione dei genitori possa rappresentare un indicatore rilevante di vulnerabilità psicologica nei figli e sottolineano come un approccio di affermazione immediata non sia idoneo a garantire un percorso di sviluppo sicuro ed equilibrato.
Le percezioni dei genitori
L’ambivalenza genitoriale e i dubbi sull’autenticità
Molti genitori hanno vissuto la rivelazione dell’identità transgender dei propri figli, spesso accompagnata da richieste immediate di cambiamento di nome e pronomi, con smarrimento e impotenza.
È emerso un conflitto interiore tra il desiderio di aiutare i figli e la difficoltà a riconoscere come autentiche le dichiarazioni rese dai giovani, perché percepite come improvvise, eterodirette o influenzate da forum online e comunità social.
La frattura familiare e la paura del confronto
Dopo la rivelazione, la possibilità di discutere apertamente è diventata spesso difficile.
Domande e perplessità dei genitori sono state accolte dai figli come segnali di incomprensione o intolleranza, minando il confronto costruttivo.
In diversi casi, i genitori hanno riferito che il termine “transfobia” è stato usato dai figli come strumento per neutralizzare ogni critica, generando un clima conflittuale e un silenzio forzato.
Discrepanze comportamentali e disagio sottostante
Molti genitori hanno notato incongruenze tra il comportamento precedente dei figli e la sicurezza ostentata dopo la rivelazione. Le spiegazioni fornite apparivano spesso superficiali o incoerenti, rafforzando nei genitori l’idea che la questione identitaria potesse essere, almeno in parte, una modalità per elaborare un disagio emotivo più ampio. In questo senso, le narrazioni identitarie venivano vissute come difese rigide, più che come espressioni autentiche di un percorso maturato.
Un elemento ricorrente nelle testimonianze è la natura inaspettata della rivelazione, senza alcun precedente segnale.
La richiesta era spesso accompagnata da un senso di urgenza, che i genitori hanno vissuto come una pressione a prendere decisioni irreversibili in tempi troppo ristretti.
Fattori scatenanti e vulnerabilità adolescenziale
Un gran numero di genitori ha collegato l’emergere della richiesta di transizione a un insieme di circostanze esterne come le difficoltà tipiche della pubertà, le delusioni relazionali e, soprattutto, l’impatto del lockdown da COVID-19, che ha amplificato il senso di isolamento e intensificato l’uso dei social network.
In questo contesto, i figli vengono percepiti come particolarmente fragili, alle prese con sfide emotive e identitarie che vanno oltre la sola questione di genere. Ansie legate al corpo, disturbi alimentari, difficoltà con lo sviluppo precoce e pressioni sociali sono percepite come fattori aggravanti che rendono i figli particolarmente fragili. In alcuni casi l’identità transgender è stata percepita come meccanismo di coping.
Sessualità in evoluzione e identità fluide
Molti giovani avevano inizialmente fatto coming out come omosessuali o bisessuali, con una progressione identitaria interpretata dai genitori come parte di un’esplorazione adolescenziale piuttosto che come una traiettoria definitiva meritevole di intervento medicale e chirurgico.
L’influenza dei social network e delle comunità online
Un ruolo centrale viene attribuito alle comunità digitali e ai social media, in particolare TikTok, Instagram e forum online dedicati all’identità di genere.
I genitori hanno osservato come il linguaggio e i concetti utilizzati dai figli ricalcassero spesso quello circolante in tali ambienti, interpretando questa influenza come un fattore che rafforza narrative standardizzate sull’identità transgender, spesso percepite dai genitori come ideologicamente orientate.
Identità come costruzione relazionale e culturale
Dalle testimonianze emerge l’idea che la ricerca identitaria dei figli non fosse il frutto di un percorso solitario e lineare, quanto piuttosto l’esito di un intreccio tra fragilità personali, influenze relazionali e dinamiche culturali.
L’assunzione di un’identità transgender è stata spesso vista come parte di una strategia adattativa reattiva, sottolineando la necessità di una valutazione psicologica attenta e non riducibile a un’immediata conferma medica.
I consulti clinici
Consultazioni percepite come orientate all’affermazione
Molti genitori hanno descritto le consulenze specialistiche come eccessivamente focalizzate sull’affermazione dell’identità transgender, con scarsa attenzione al contesto psicologico e alle esperienze pregresse dei figli.
La diagnosi di disforia di genere veniva percepita come troppo rapida e standardizzata.
Esclusione dei genitori dal percorso decisionale
Oltre la metà dei genitori non è stata coinvolta nelle consulenze, mentre altri hanno avuto un ruolo marginale. Ciò ha generato frustrazione e senso di solitudine, con le loro preoccupazioni spesso trascurate, lasciandoli a gestire da soli dubbi e tensioni emotive.
Diagnosi rapide, consultazioni superficiali e pressioni psicologiche
Pochi incontri sono stati sufficienti per avviare la transizione.
Questa rapidità è stata vissuta come un segnale di superficialità, con scarsa attenzione alle cause profonde del disagio. Alcuni resoconti descrivono l’uso di pressioni psicologiche da parte dei professionisti, come il riferimento a rischi di suicidio, percepiti dai genitori come strumenti per orientare il loro consenso. Altri hanno osservato che i colloqui si concentravano quasi esclusivamente sugli aspetti pratici della transizione, trascurando una reale esplorazione del vissuto psicologico dei figli.
Rottura con la famiglia e sfiducia nel sistema
Alcuni genitori hanno raccontato episodi in cui i professionisti avrebbero incoraggiato i figli ad allontanare i familiari, scoraggiando l’analisi delle possibili cause del desiderio di transizione e spostando l’attenzione sulla “resistenza” dei genitori.
Queste esperienze hanno alimentato un diffuso senso di sfiducia verso un sistema percepito come poco equilibrato e scarsamente attento alla complessità dei percorsi individuali.
Percorsi di transizione e ansia per la salute e il futuro del figlio
Questo percorso clinico ha generato nei genitori una forte preoccupazione per possibili pentimenti futuri e per gli effetti sulla salute dei figli, percepiti come troppo giovani o troppo vulnerabili per scelte così irreversibili, aumentando in tal modo il senso di responsabilità e ansia vissuto dai genitori.
Deterioramento del benessere psicologico dopo la rivelazione
Dopo la rivelazione i genitori hanno osservato un peggioramento del benessere dei figli, con sintomi psicologici accentuati, comportamenti problematici, tensioni familiari e ridotto coinvolgimento scolastico.
Molti giovani comunicavano a stento con i genitori, reagivano con veemenza alle discussioni e utilizzavano minacce di suicidio o di allontanamento, talvolta con esternazioni aggressive e violente, per costringere i genitori ad autorizzare gli interventi medici.
Anche nei casi di sostegno alla transizione, si sono riscontrati cali scolastici, abbandono di attività e conflitti familiari, con sintomi depressivi, ideazione suicidaria, instabilità emotiva e maggiore dipendenza dai social media.
Desistenza e riconsiderazione della transizione
Alcuni giovani hanno deciso di interrompere la transizione, trovando sollievo.
Alcuni giovani desister hanno confermato che l’identità transgender era stata modellata su informazioni online, usate per comprendere il proprio disagio, evidenziando la fluidità delle esperienze adolescenziali.
Le conclusioni dello studio
Dall’analisi delle percezioni genitoriali, gli autori dello studio sono giunti alle seguenti conclusioni.
Necessità di approcci clinici più articolati e personalizzati
I risultati evidenziano le difficoltà dei genitori di fronte alla rivelazione di trans-identità dei figli, tra ambivalenza, isolamento e preoccupazioni sul supporto clinico, in particolare per valutazioni psicologiche approfondite.
Si sottolinea la necessità di approcci clinici personalizzati, che considerino il benessere del giovane e della famiglia e guidino lo sviluppo di best practice.
L’importanza di un supporto psicologico individualizzato
I genitori desiderano sostenere i figli mantenendo un dialogo aperto, ma temono interventi medici prematuri.
È fondamentale un supporto psicologico individualizzato per promuovere relazioni costruttive, riflessione prima di decisioni irreversibili e coinvolgimento della famiglia nel processo decisionale.
Disponibilità dei genitori e dovere di fornire informazioni corrette
Molti genitori dimostrano un atteggiamento proattivo, cercando informazioni, risorse e consulenze per comprendere meglio l’esperienza dei figli. Questo impegno non riflette opposizione, ma volontà di comprendere il giovane con attenzione e aiutarlo a gestire meglio le proprie difficoltà.
I dati evidenziano la necessità di accesso a informazioni equilibrate e basate sull’evidenza, così da guidare le famiglie nelle decisioni più complesse.
Dialogo aperto ed empatia familiare
Una comunicazione empatica tra genitori e figli è fondamentale, ma questa è a volte inibita anche da ostacoli involontari, poiché i giovani possono rinchiudersi in loro stessi, percependo la loro identità come risposta a un disagio emotivo, mentre i genitori, nel tentativo di comprendere, rischiano di creare barriere involontarie.
I professionisti sanitari devono facilitare un dialogo rispettoso, assicurando che le preoccupazioni dei genitori vengano ascoltate, evitando esclusione e marginalizzazione nelle consulenze specialistiche.
Preoccupazioni sul benessere psicologico
I genitori esprimono ansia per il benessere psicologico dei figli, soprattutto in presenza di condizioni di salute mentale preesistenti.
Queste preoccupazioni non indicano opposizione, ma protezione e responsabilità educativa.
Incontri clinici che trascurano queste inquietudini possono intensificare ansia e isolamento.
Influenze esterne e contesto psicosociale
Social media, comunità digitali e relazioni tra pari influenzano lo sviluppo dell’identità.
Questi fattori, pur non invalidando la trans-identificazione, richiedono una considerazione attenta e individualizzata nel percorso di valutazione e supporto psicologico.
Raccomandazioni per un approccio psicoterapeutico integrato
Il supporto iniziale dovrebbe concentrarsi sulla psicoterapia e sull’esplorazione delle motivazioni, inserendo eventuali interventi medici in un quadro più ampio di assistenza psicosociale, che includa:
- un dialogo empatico tra genitori e figli;
- la considerazione dei bisogni psicologici sottostanti;
- la protezione da decisioni premature;
- la promozione di dinamiche familiari sicure e costruttive.
Approccio interdisciplinare e prudenza clinica
Le sfide della trans-identità richiedono interventi interdisciplinari che integrino prospettive mediche, psicologiche e sociali.
Strategie psicoterapeutiche basate su esplorazione e comprensione, piuttosto che sull’affermazione immediata, tutelano lo sviluppo dell’adolescente e il benessere familiare.
Allineamento con linee guida e valutazioni psicosociali
Queste indicazioni sono coerenti con la Cass Review (Cass, 2024), che promuove valutazioni psicosociali complete prima di interventi medici, supportando le famiglie in modo olistico, bilanciando tutela, sostegno e prudenza clinica.