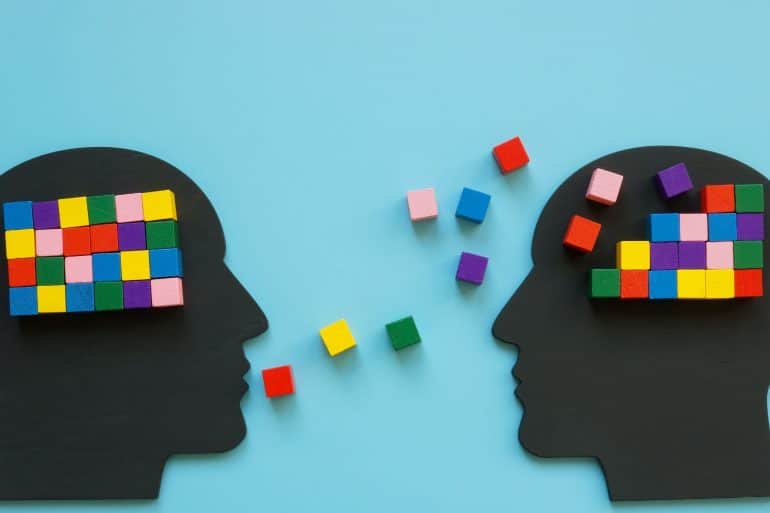Psicoterapia e disforia di genere negli adolescenti: un presidio clinico indispensabile
Negli ultimi anni, la gestione della disforia di genere in età evolutiva si è collocata al centro di un intenso dibattito scientifico e sociale. Il cosiddetto modello affermativo — caratterizzato dalla rapida convalida dell’identità transgender dichiarata dal giovane e dall’avvio di percorsi di transizione sociale e medica — ha progressivamente acquisito una posizione dominante in numerosi contesti clinici internazionali. Tuttavia, le evidenze scientifiche a sostegno di tali pratiche si rivelano, ad oggi, limitate e controverse. Diverse revisioni sistematiche (UK, Svezia, Finlandia) hanno evidenziato che gli interventi di blocco puberale e l’utilizzo di ormoni cross-sex presentano benefici scarsamente documentati e, al contrario, rischi significativi in termini di salute fisica, fertilità e funzione sessuale.
In questo scenario, la psicoterapia si trova a occupare una posizione ambivalente: da un lato, viene talvolta marginalizzata o sostituita da protocolli standardizzati di affermazione di genere; dall’altro, quando proposta come percorso esplorativo, viene talora impropriamente assimilata alle cosiddette “terapie di conversione”.
Come sottolinea il Dr. Roberto D’Angelo nel contributo Supporting autonomy in young people with gender dysphoria: psychotherapy is not conversion therapy, tale assimilazione appare concettualmente e clinicamente infondata, poiché la psicoterapia, nelle sue declinazioni contemporanee, non si pone come obiettivo la modifica forzata dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.
Psicoterapia: un presidio di esplorazione e sostegno
La psicoterapia, in questo scenario, rappresenta invece un presidio fondamentale. Non si propone di negare l’autodeterminazione del giovane, bensì di sostenerla, fornendo uno spazio in cui sia possibile:
- Esplorare i vissuti sottostanti: ansia, depressione, esperienze traumatiche, difficoltà nel rapporto con il corpo, dinamiche familiari.
- Dare voce alle ambivalenze: molti adolescenti sperimentano oscillazioni identitarie; la psicoterapia offre un luogo sicuro per esprimerle senza giudizio.
- Rafforzare le funzioni riflessive: la capacità di tollerare l’incertezza, di riflettere sulle proprie emozioni e di differire decisioni affrettate è parte integrante della maturazione psichica.
- Prevenire scelte premature: avviare trattamenti medici irreversibili senza aver esplorato i molteplici fattori psicologici in gioco può compromettere il futuro benessere dell’individuo.
È dunque cruciale distinguere tra psicoterapia come esplorazione e terapie di conversione come imposizione: la prima è un sostegno al processo di individuazione, la seconda è una violazione della dignità della persona.
L’equiparazione della psicoterapia alla conversion therapy comporta il rischio concreto di privare gli adolescenti di uno strumento essenziale di sostegno, riducendo l’intervento clinico a un percorso unidirezionale e medicalizzante.
Adolescenza, identità e complessità clinica
L’adolescenza costituisce una fase di sviluppo intrinsecamente complessa, caratterizzata da trasformazioni corporee, emotive e relazionali che pongono il giovane in una condizione di vulnerabilità. È un periodo di sperimentazione e ricerca di sé, in cui l’identità — sessuale, sociale, relazionale — è ancora in costruzione.
In questo quadro, i sintomi di disforia di genere non possono essere letti esclusivamente come la prova di un’identità transgender “autentica e definitiva”. Possono, invece, rappresentare l’espressione di una sofferenza più ampia, legata a depressione, ansia, disturbi dell’alimentazione, difficoltà relazionali o traumi pregressi.
In particolare, il fenomeno del rapid onset gender dysphoria (ROGD), segnalato da alcuni clinici, mette in luce come in molti casi il disagio emerga improvvisamente in adolescenza, in concomitanza con esposizione massiccia ai social media e con dinamiche di gruppo fortemente identificatorie.
Ignorare questa complessità significa ridurre la sofferenza a una diagnosi unica, rischiando di medicalizzare in modo precoce e irreversibile ciò che potrebbe essere un passaggio transitorio.
Un approccio rigidamente affermativo rischia infatti di ridurre tale complessità a una diagnosi lineare, aprendo la strada a interventi irreversibili senza una valutazione adeguata dei determinanti psicologici sottostanti.
Al contrario, la psicoterapia consente di:
- sostenere un processo di chiarificazione, tollerando l’incertezza e l’evoluzione delle narrazioni identitarie;
- individuare eventuali co-morbidità psichiatriche o problematiche familiari e relazionali;
- prevenire scelte impulsive e potenzialmente dannose.
L’assenza della psichiatria nel dibattito
Uno degli aspetti più preoccupanti messi in luce dagli studiosi riguarda proprio la progressiva marginalizzazione della psichiatria e della prospettiva psicodinamica all’interno del dibattito.
La psichiatria, tradizionalmente, si occupa di decifrare la complessità delle condizioni di sofferenza psichica, integrando fattori biologici, psicologici e sociali. Tuttavia, nel campo della disforia di genere, molti servizi hanno adottato un approccio prevalentemente biomedico, limitandosi a validare la richiesta di transizione e trascurando le dimensioni inconsce, relazionali e familiari.
L’assenza di una cornice psichiatrica esplorativa ha due conseguenze principali:
- Sovradiagnosi di disforia: il rischio che altri disturbi psichici vengano oscurati dall’etichetta di “gender dysphoria” (fenomeno definito diagnostic overshadowing).
- Medicalizzazione precoce: la riduzione del disagio a una condizione con “soluzione unica” (transizione), invece di una comprensione più articolata dei fattori di vulnerabilità.
Il risultato è che il compito centrale dello psichiatra — aiutare a dare significato al sintomo, valutare la complessità e proteggere il paziente da interventi potenzialmente dannosi — viene messo in secondo piano.
La funzione etica della psicoterapia
Il contributo di D’Angelo invita i professionisti a riflettere anche sul valore etico della psicoterapia in questo ambito. Lungi dal costituire un ostacolo all’autodeterminazione, essa ne rappresenta la condizione necessaria: solo un giovane che ha potuto esplorare la propria sofferenza in profondità può assumere decisioni realmente libere e consapevoli.
La rapidità con la quale talvolta si passa dal disagio all’avvio di protocolli medici standardizzati rischia di rispondere più a pressioni sociali e a difese contro l’incertezza, che a un’autentica valutazione clinica. La psicoterapia, invece, salvaguarda lo spazio dell’ascolto, della riflessione e della complessità, fungendo da barriera protettiva contro decisioni premature.
I professionisti della salute mentale hanno delle precise responsabilità etiche nell’attuare un doveroso bilanciamento fra rispetto dei sentimenti di autodeterminazione e protezione dal danno.
Per tale motivo devono attenersi ai seguenti principi:
- Autonomia autentica: la libertà decisionale presuppone consapevolezza. Un giovane che prende decisioni su trattamenti irreversibili, senza aver esplorato a fondo le proprie motivazioni, non esercita un’autonomia autentica.
- Principio di non maleficenza: avallare percorsi medici senza un’adeguata valutazione rischia di arrecare danni irreversibili.
- Diritto al dubbio: la psicoterapia difende il diritto all’incertezza, che fa parte integrante del processo di crescita.
In questo senso, la psicoterapia non ostacola il diritto all’autodeterminazione: ne è la condizione necessaria.
Prospettive per la pratica clinica
Per la comunità degli psicologi e psichiatri, questo implica la necessità di:
- Riaffermare il valore dell’esplorazione clinica: la psicoterapia deve essere offerta come primo intervento, non come opzione residuale nella presa in carico della disforia di genere.
- Contrastare le semplificazioni: contrastare la riduzione del lavoro clinico a mera validazione di un’identità predefinita.
- Promuovere una cultura del dubbio: tollerare l’incertezza e resistere alle pressioni sociali per soluzioni rapide è parte integrante del compito clinico.
- Formare i professionisti: serve un aggiornamento continuo su disforia, adolescenza e psicopatologia, affinché la valutazione non si riduca a protocolli standardizzati.
- Riconoscere che l’accusa di “conversion therapy” non può essere utilizzata per silenziare il lavoro psicoterapeutico fondato su principi di rispetto, ascolto e sospensione del giudizio.
Conclusioni
La gestione della disforia di genere in età evolutiva richiede pertanto un approccio equilibrato, capace di integrare il rispetto per l’autodeterminazione dei giovani con la responsabilità di proteggerli da scelte affrettate e irreversibili.
La psicoterapia, intesa come spazio di esplorazione e sostegno, si configura non come una minaccia alla libertà identitaria, bensì come il presupposto stesso della sua autentica realizzazione.
Marginalizzarla o confonderla con pratiche coercitive significa tradire la missione della psichiatria e della psicologia: prendersi cura della persona nella sua interezza, non ridurre il sintomo a una diagnosi lineare.
Solo attraverso percorsi esplorativi, rispettosi e privi di ideologie, sarà possibile garantire ai giovani non solo l’affermazione di sé, ma soprattutto la possibilità di scelte davvero consapevoli e orientate al loro benessere futuro.