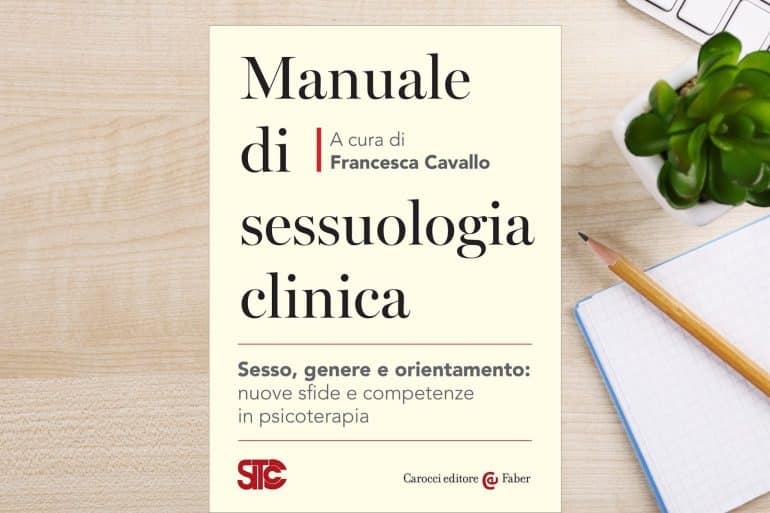Baiardini, Dimaggio e Del Giudice sui bloccanti della pubertà
L’utilizzo dei bloccanti della pubertà per la disforia di genere, tra complessità psicologica e responsabilità clinica.
Nel Manuale di Sessuologia Clinica a cura di Francesca Cavallo, gli studiosi Ilaria Baiardini (Università di Genova, DiMI), Giancarlo Dimaggio (Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma) e Marco Del Giudice (Università di Trieste) offrono un contributo di grande rigore scientifico e chiarezza metodologica su uno dei temi più controversi della medicina e della psicologia contemporanea: l’uso dei bloccanti della pubertà negli adolescenti con disforia di genere. L’analisi coniuga una lettura storica e scientifica con riflessioni etiche e cliniche, restituendo un quadro equilibrato che invita alla prudenza, alla complessità e alla centralità del pensiero terapeutico.
Dalle origini sperimentali al protocollo standardizzato
Gli autori ricordano che l’uso dei bloccanti della pubertà (GnRHa) nasce in Olanda a metà degli anni ’90 grazie al lavoro di Peggy Cohen-Kettenis, presso la clinica di Amsterdam. L’obiettivo iniziale del cosiddetto protocollo olandese era duplice: offrire agli adolescenti del tempo per riflettere sulla propria identità e ottenere risultati estetici migliori per chi avesse deciso di proseguire nella transizione. Il modello, standardizzato nel 2006 (Delemarre-van de Waal & Cohen-Kettenis), prevedeva l’avvio del blocco già allo stadio Tanner 2 dello sviluppo adolescenziale, seguito da ormoni cross-sex e, dopo la maggiore età, potenziali interventi chirurgici.
In pochi anni, il protocollo si è diffuso in tutto il mondo, divenendo riferimento nelle linee guida internazionali (Hembree et al., 2009). I due studi longitudinali di de Vries et al. (2011, 2014), nonostante i limiti di campione, hanno contribuito a consolidare l’idea che il blocco puberale potesse migliorare il benessere psicologico dei giovani con disforia di genere.
Crisi di un modello e nuove evidenze scientifiche
Nel decennio successivo, tra il 2010 e il 2020, l’aumento esponenziale dei casi di disforia di genere – soprattutto tra le ragazze adolescenti – ha sollevato interrogativi sull’effetto di una diffusione eccessiva dell’approccio affermativo, tanto che alcuni autori hanno ipotizzato una forma di epidemia sociale (Littman, 2018). Parallelamente, la revisione critica degli studi olandesi ha messo in luce limiti metodologici rilevanti: campioni ridotti, bias di selezione e mancanza di controlli adeguati (Abbruzzese et al., 2023; Biggs, 2023).
Lo studio di Carmichael et al. (2021), che ha cercato di replicare i risultati olandesi, non ha riscontrato miglioramenti psicologici significativi, ma ha evidenziato effetti collaterali sull’accrescimento osseo. Anche l’idea che i bloccanti riducano il rischio suicidario si fonda su dati deboli, derivati da un unico studio retrospettivo (Turban et al., 2020) privo di solidità causale.
Infine, l’ipotesi della reversibilità del trattamento è stata ampiamente ridimensionata: mancano dati sull’essere umano, mentre studi su altri mammiferi indicano effetti neurocognitivi potenzialmente permanenti (Baxendale, 2024). A ciò si aggiunge un dato clinico inequivocabile: oltre il 90% dei pazienti che inizia i bloccanti prosegue la transizione con ormoni e chirurgia (Brik et al., 2020; Wiepjes et al., 2018), segno che il blocco non rappresenta una pausa esplorativa, ma un passo irreversibile nel percorso medico.
Un dibattito in evoluzione: scienza, etica e istituzioni
I tre autori segnalano che le revisioni sistematiche più recenti (Bragge et al., 2024; Taylor et al., 2024; Thompson et al., 2023; Zepf et al., 2024) convergono su un punto chiave: le evidenze sull’efficacia e la sicurezza dei bloccanti della pubertà sono ancora deboli e frammentarie. La Cass Review (2024), commissionata dal Servizio Sanitario Nazionale inglese, ha sintetizzato questa incertezza e raccomandato un ritorno a una medicina basata su prove, evitando derive ideologiche.
Anche in Italia si osserva un simile cambiamento di rotta. L’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) ha raccomandato la creazione di un registro nazionale e studi di follow-up indipendenti (AIP, 2024), mentre il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha riformulato il proprio parere del 2018, riconoscendo la carenza di dati e auspicando ricerche più solide e multidisciplinari (CNB, 2024).
Ripensare la clinica: il ruolo imprescindibile della psicoterapia
Nella parte conclusiva del capitolo, Baiardini, Dimaggio e Del Giudice evidenziano come la crisi del protocollo olandese rappresenti un’occasione per ripensare l’intervento clinico alla luce della complessità psicologica dei giovani pazienti. Gli adolescenti con disforia di genere presentano spesso comorbilità psichiatriche importanti – depressione, ansia, disturbi del comportamento, autismo, traumi – che richiedono tempo, valutazioni accurate e percorsi personalizzati (Lambruschi, 2024).
L’approccio affermativo, focalizzato unicamente sull’identità di genere, rischia invece di oscurare le altre dimensioni della sofferenza, favorendo decisioni premature e medicalizzazioni non necessarie. Gli autori ricordano che la psicoterapia esplorativa non è terapia di conversione, ma uno strumento clinico essenziale per promuovere autonomia, consapevolezza e riflessione, permettendo scelte più autentiche e meno impulsive.
Il loro messaggio è chiaro: in un campo segnato da incertezze e polarizzazioni, solo un approccio che unisca prudenza scientifica, ascolto psicologico e responsabilità etica può garantire il benessere reale dei giovani con disforia di genere. Recuperare la centralità del pensiero clinico e del tempo terapeutico diventa, oggi più che mai, il vero antidoto contro le semplificazioni ideologiche e le scorciatoie mediche.